Ieri (due dicembre) hanno liberato Robert!
È libero e senza misure e sta bene!
Beppe e Nat invece rimangono ancora in carcere, rispettivamente a Pavia e Piacenza.
Seguiranno aggiornamenti!
Categoria: Informazione
Apocalissi e ragion di Stato

A Parigi, Robert Oppenheimer ha dichiarato che, lui, all’Apocalissi atomica ci crede; e ha anche spiegato che, per Apocalissi, egli intende la distruzione dell’umanità, non solo un qualche immenso disastro: «Non è più lecito credere che il genere umano possa sopravvivere a una guerra atomica». Interrogato sull’efficacia di un controllo internazionale o di un accordo di disarmo, il celebre fisico ha risposto che si tratta di palliativi, e per di più irrealizzabili, perché, data l’evoluzione attuale della scienza, ogni misura di controllo su cui ci si accordasse sarebbe probabilmente superata dopo due anni.. Quanto alla «bomba pulita» di cui va così fiero il suo collega Edward Teller, Oppenheimer ha fatto notare che si tratterebbe pur sempre di un congegno capace di distruggere ogni cosa nel raggio di ottocento chilometri quadrati, quindi non eliminerebbe il carattere di «suicidio cieco» implicito nell’uso di armi simili. La ragione del pessimismo di Oppenheimer è semplice: egli non ha alcuna fiducia nella saggezza non solo, ma neppure nel semplice comprendonio, degli uomini di Stato, dei militari e degli esperti da cui dipendono, oggi, le «grandi decisioni». Lo scienziato non dice che gli uomini di Stato, i militari e gli esperti sono dei folli e degli stupidi; dice che essi si trovano in una situazione tale da non poter agire altro che follemente e stupidamente: devono cioè ignorare deliberatamente l’enormità dei problemi che la loro azione solleva. Se la riconoscessero dovrebbero cessare di agire come agiscono, ma per riconoscerla dovrebbero adottare un principio d’azione diverso da quello che solo capiscono: la ragion di Stato. Le armi atomiche, e quelle non meno terribili di cui non si parla ma che esistono, esigerebbero che si pensasse in termini di destino dell’umanità e di natura dell’universo, non di Stati. Ma l’universo e l’umanità son concetti vaghi, quello di Stato invece è un concetto preciso, o così sembra. Quindi si è disposti a adottare tutti i palliativi immaginabili (e anche questo solo in teoria), ma non le misure radicali, sole efficaci. E la misura più radicalmente indispensabile, oggi, sarebbe l’adozione di modi di pensare commisurati alla realtà nuova di un mondo dove tutto è possibile, niente è certo, e nel quale ogni presunzione di certezza rischia di causare catastrofi. Quali siano questi modi di pensare adeguati, tuttavia, nessuno lo sa: neppure gli scienziati. Ci vorrebbe un nuovo tipo di filosofo per cominciare a indicarli, dice Oppenheimer. Oggi come oggi, si può soltanto dire che l’umiltà, la cautela, il riconoscimento della propria ignoranza ne sarebbero i postulati primi. Oppenheimer descrive la situazione morale dello scienziato contemporaneo in questi termini: «Lo sviluppo delle scienze è stato accompagnato da una specializzazione tale che qualsiasi uomo, oggi, può possedere solo un’infima particella delle conoscenze umane. Questo suscita un sentimento d’ignoranza e di solitudine la cui intensità sembra proporzionale al sapere... Per quanto concerne gli scienziati atomici, a questo smarrimento si aggiunge la paura di un’arma della quale nessuna cifra ha esagerato l’orrore e che dovrebbe riempire di sgomento l’animo di ogni uomo onesto che si trova a esercitare un potere». Il paradosso proprio della scienza moderna è che questo sentimento d’ignoranza e di solitudine, questa riduzione di ciò che un individuo può sapere a una particella sempre più infima, si accompagna alla certezza di un’apertura di orizzonti sconfinati di conoscenza e di potere. «L’idea di progresso scientifico mi sembra ormai indissolubilmente legata alla nozione di destino umano», dice Oppenheimer; e si può supporre che voglia dire fra l’altro che nessun acquisto di conoscenze, oggi, rimane puramente teorico: anche le più astruse costruzioni della matematica possono tradursi in mezzi per influenzare, modificare, o minacciare le condizioni dell’esistenza umana. Lo scienziato non può quindi in nessun momento sentirsi esente da responsabilità, libero di giocare con le ipotesi, fiducioso, come nel secolo scorso, che le sue scoperte non possono, in definitiva, che servire l’umanità. Secondo Oppenheimer, lo scienziato non può più neppure contare sull’idea che dal limite sempre più ristretto di ciò che un individuo può sapere e dall’accrescersi vertiginoso delle conoscenze, si finirà con lo sboccare in una sintesi armonica e globale: «La conoscenza non avrà mai più, a mio parere, un carattere globale... Siamo condannati a vivere in un mondo in cui, da ogni problema che si ponga, un altro ne sorgerà immediatamente, e così all’infinito. Uno dei caratteri angosciosi della conoscenza è la sua irreversibilità. Temo che quelli che aspirano oggi alla sintesi o all’unità non facciano che invocare un’epoca scomparsa. Credo che una tal sintesi non si potrebbe ottenere che a un prezzo o della tirannia o della rinunzia. La sola via aperta mi sembra quella della ricerca di un equilibrio: a questo lo scienziato si esercita continuamente. Egli è obbligato all’equilibrio dalla disciplina scientifica stessa, che gli impone di distinguere il nuovo dall’abituale, l’essenziale dal superfluo, l’eroismo dalla servitù. La scienza esige una nozione di verità scevra d’ambiguità... implica necessariamente una fraternità e comunanza di spirito e d’azione senza di cui l’uomo rimarrebbe impotente, prigioniero di una visione troppo angusta della propria condizione, in un universo troppo complesso e troppo vasto. Se l’esperienza dello scienziato si potesse comunicare — e mi sembra importante che lo sia — essa permetterebbe di preparare un maggior numero d’individui alla difficile situazione dell’uomo dinanzi all’universo, situazione di fronte alla quale sia i filosofi che i governanti di oggi mi sembrano crudelmente anacronistici». Oppenheimer, dunque, predica l’umiltà e l’equilibrio. La lezione, egli l’ha imparata da un’esperienza che non potrebb’essere più probante: dall’essersi trovato, lui scienziato, molto in alto fra quelli che ebbero a prendere grandi decisioni, e dall’avere egli stesso agito follemente, ossia senza sapere quel che faceva, privo di un criterio di scelta sicuro, alla cieca e per cieca necessità. Aveva fabbricato la bomba atomica senza sapere né se sarebbe riuscito, né che cosa esattamente avrebbe fatto se fosse riuscito; quando fu fabbricata, non seppe con certezza che uso se ne dovesse fare: se fosse logico usarla contro i giapponesi, ovvero — come proponevano alcuni scienziati — dare soltanto la dimostrazione spettacolare della sua potenza. Nel dubbio, egli fu d’accordo con gli uomini di Stato e i militari, i quali naturalmente pensavano che un’arma è un’arma: è fatta per annientare il nemico, non per essere «dimostrata». E si trova ancor oggi, Oppenheimer, a non saper dire quel che fosse giusto allora: «per quanto mi riguarda — egli ha confessato — non mi sentirei capace neppure dopo tanti anni di assumere la responsabilità che incombette agli Stati Uniti nel 1945». La responsabilità era troppo grande per una semplice coscienza d’individuo. Fu quindi presa da uno Stato, per ragioni di Stato. Le ragioni di Stato non erano certo più chiaroveggenti di quelle di fisici come Franck e Szilard: erano soltanto più forti nell’immediato. Quegli scienziati pensavano all’avvenire, mentre i generali e i governanti pensavano all’immediato presente: terminare la guerra d’un colpo, con una prova di potenza sconfinata. Gli scienziati avevano ragione quanto all’avvenire. Ma la bomba era stata fabbricata per conto di uno Stato, ed era normale che le ragioni di Stato prevalessero: avevano anch’esse una loro logica, che era la logica dei risultati immediati. Nell’immediato, quel che occorreva era la certezza dell’efficacia massima, e questa non si poteva avere che servendosi della bomba sul serio. Poi si sarebbe visto. Quel che si è visto è la prosecuzione meccanica della logica della ragion di Stato, la logica dell’immediato e dell’efficacia. Si è arrivati a una situazione, la presente, in cui la decisione se usare o no le armi assolute finisce col dipendere non da una decisione umana, ma da un calcolo elettronico delle probabilità più o meno grandi che una certa situazione individuata da certe macchine sia quella in cui un certo Stato, essendo minacciato di morte imminente, non ha altra scelta che scatenare sull’avversario la medesima minaccia. Non si sapeva dove si andava nel 1945, lo si sa sempre meno oggi. In compenso, la certezza dell’efficacia massima non manca davvero, anzi cresce continuamente. Ciò che manca è quel senso d’umiltà e d’equilibrio che dovrebbe nascere, in «ogni uomo onesto», dallo sgomento di trovarsi a esercitare un potere smisurato essendo certo solo della propria ignoranza. Invece, dall’ignoranza abissale in cui sono dell’«universo troppo vasto e troppo complesso» che ci circonda e ci domina, gli odierni governanti non sanno trarre altro consiglio che quello di spingere comunque le cose agli estremi. Il colmo dell’ubris.
Nicola Chiaromonte in Tempo Presente (1958)
Tratto da: Finimondo
Biglietti da visita
Si sa che uno dei biglietti da visita lasciati dalle insurrezioni nella storia è la possibilità di partire da un pretesto banale, facendo esplodere in modo inaspettato le contraddizioni sociali che fremono da troppo tempo. Non è forse stata nel dicembre 2010 l'autoimmolazione di un giovane venditore ambulante tunisino, stanco delle vessazioni poliziesche in una vita di miseria, ad aver dato fuoco alle polveri della cosiddetta primavera araba, per poi incendiare la Tunisia e l’Egitto, passando per la Libia e la Siria? E non è stata una disputa a proposito di cannoni pagati tramite sottoscrizione popolare durante una guerra persa la scintilla che ha provocato l'insurrezione della Comune di Parigi nel marzo 1871, spalancando un ardente immaginario fino ai giorni nostri? A fine gennaio 2019, quando il prezzo del biglietto a Santiago del Cile è stato aumentato fino a raggiungere la quota simbolica di 800 pesos per la metropolitana e 700 pesos per gli autobus... non è successo nulla. Ma appena è stato annunciato un ennesimo aumento dieci mesi dopo di 30 pesos per l’una e 10 pesos per gli altri, alcuni liceali hanno iniziato a frodare la metropolitana della capitale per protesta. Le prime frodi il 7 ottobre fino alla loro moltiplicazione la settimana seguente hanno causato la chiusura delle stazioni da parte delle autorità, lo sfondamento dei cancelli della metropolitana fino agli scontri con i carabinieri da entrambi i lati delle obliteratrici il 17 ottobre, e in men che non si dica la rivolta in Cile è esplosa il giorno successivo, dopo di che il 19 ottobre è stato decretato lo stato di emergenza col coprifuoco militare. I primi contestatori hanno forse messo in discussione quella infrastruttura costruita per spostare flussi di schiavi verso il loro luogo di sfruttamento e di consumo? No, chiedevano solo di poterla usare senza che ciò gravasse troppo sulle loro tasche. Era un movimento di disobbedienza senza concessioni (per non pagare di più e incitare gli altri a farlo), di protesta contro il carovita. Una vita che molti immaginavano allora di continuare a condurre nella stessa triste galera, tra vari lavori per far quadrare i conti, arrangiandosi economicamente, un debito a lungo termine per coloro che hanno studiato, una pensione miserabile affidata ai fondi privati e una salute in cui si crepa per il dolore quando non ci si può permettere le medicine, il tutto in un territorio in cui i più ricchi che costituiscono l'1% possiedono più del 25% del Pil nazionale essendosi arricchiti durante gli sfarzi della dittatura militare del generale Pinochet. Affinché la rivolta esplodesse, è stato necessario certamente che una piccola minoranza gioiosa quanto arrabbiata lanciasse una scintilla, oltre ad un piccolo ingrediente supplementare: l'azione diretta diffusa che rovescia il tavolo al momento giusto. Ed ecco che migliaia di giovani si scontrano giorno dopo giorno con la polizia per frodare rendendo la metropolitana gratuita di fatto, e poi degli sconosciuti cominciano a rimuovere la questione stessa saccheggiando e distruggendo le stazioni, con la loro parte di negozi, gli erogatori di biglietti, i bancomat, i loro sistemi elettrici e persino i loro convogli! Nel giro di un fine settimana, dal 18 al 20 ottobre, metà delle stazioni del sistema di trasporto sotterraneo cileno sono state messe fuori servizio (25 incendiate e 93 danneggiate) e più di 2800 autobus sono stati attaccati. Questo segnale è stato ben compreso malgrado il coprifuoco militare, poiché l'intera Grande Santiago si è immediatamente incendiata, così come tutte le principali città da nord a sud, e questo già da quattro settimane. Centinaia di supermercati sono stati saccheggiati e devastati di giorno come di notte o dati alle fiamme, così come quasi 300 farmacie, 68 tribunali, sedi di partito di destra e di sinistra (dall’UDI di Santiago al RN di Melipilla e al PS di Valvidia), chiese, municipi e prefetture, banche e centri commerciali, fondi pensione e agenzie ministeriali, scuole e imprese agroforestali, uffici dell’anagrafe e università, caselli autostradali e antenne di telecomunicazione. Se ciò che conta è beninteso di natura qualitativa, ovvero le capacità di attacco e distruzione contro strutture del nemico chiaramente identificate, considerate ostili e responsabili della miseria e dell'oppressione, la presenza di piccoli gruppi mobili che si conoscono e sanno muoversi (per quartieri, licei, squadre di calcio o per affinità), la simultaneità di sommosse e blocchi diffusi, il sabotaggio di infrastrutture e la spontaneità nella rivolta, proprio come il rifiuto immediato dei politicanti di tutte le sponde e la presenza di un movimento anarchico informale e basato sull'azione diretta... possiamo notare che, anche da un punto di vista quantitativo, la Camera cilena dell'edilizia (CChC) ha valutato al 15 Novembre danni per 4500 milioni di dollari, 380 dei quali per la sola metropolitana, 2330 milioni per le infrastrutture pubbliche e 2250 milioni per i locali non residenziali. Ovviamente hanno avuto la loro importanza alcuni grandi momenti collettivi, come quello del 25 ottobre coi suoi 1,2 milioni di manifestanti prima della revoca dello stato di emergenza militare, o la giornata dello sciopero generale indetto il 12 novembre, che non ha riguardato solo Il 90% del settore pubblico e il 60% del privato, ma è stato anche segnato da innumerevoli saccheggi e distruzioni col fuoco, che hanno lasciato i centri urbani come quelli di Antofagasta, Osorno, Concepción o Punta Arenas piuttosto devastati. Ma ciò non deve d’altro canto ricreare fantasie sui protagonisti di questa rivolta autonoma senza leader o partiti, che non sono né il fantomatico «popolo spettrale che si è svegliato» caro ai nazional-populisti, né la famosa «classe operaia organizzata» così cara ai dinosauri marxisti: sono tutti individui che per ragioni diverse non si aspettano nulla dal potere, né briciole né riforme costituzionali, e che hanno deciso di usare direttamente ciò che serve loro distruggendo tutto il resto. Sono coloro che hanno capito sulla propria pelle che non c'è nulla da negoziare in questo esistente, ma tante cose da demolire, perché solo partendo da questo negativo potrà nascere una vita completamente diversa. Sono coloro che sono usciti nelle strade nonostante il coprifuoco dell'esercito, e che continuano ad attaccare malgrado gli appelli alla calma e alla pace e a dispetto della repressione (2400 feriti in ospedale, colpiti soprattutto da proiettili, 26000 arrestati, tra cui diverse centinaia di torturati e 1400 incarcerati).
Ad Atene e Città del Messico si sono già svolte manifestazioni di solidarietà, a Buenos Aires e a Marsiglia è stato colpito il consolato cileno, a Salonicco è stata bruciata l'auto del console, a Montreuil una stazione della metropolitana è stata ridecorata mentre a Monaco i bancomat di diverse stazioni si sono infiammati di gioia negli ultimi giorni. È possibile che venga stampato un altro biglietto da visita delle insurrezioni passate, una solidarietà internazionale finalmente al livello della posta in gioco dell'attuale rivolta in Cile? Tanto più che non mancano certo gli ambiti dell'esistente da salutare calorosamente, magari seguendo le indicazioni che giungono da oltre la Cordigliera delle Ande…
Traduzione da Finimondo
Avis de tempêtes, n. 23, 15/11/2019 (puoi leggere qua l'ultimo numero)
Venerdì, in Università Statale a Milano: la lingua non mente
Oggi si parla molto di estirpare la mentalità del fascismo e si fa anche molto per questo fine. Si condannano i criminali di guerra, i «piccoli Pgs*» (lingua del «Quarto Reich»!) vengono licenziati, i libri nazionalisti tolti dalla circolazione, si cambia nome alle piazze Hitler e alle vie Göring, si abbattono le querce di Hitler. Ma la lingua del Terzo Reich sembra voler sopravvivere in parecchie espressioni caratteristiche, penetrate così a fondo col loro potere corrosivo da apparire come un duraturo possesso della lingua tedesca. Per esempio, quante volte nel maggio del 1945, in discorsi alla radio, in manifestazioni appassionatamente antifasciste ho sentito parlare di qualità «caratteriali» (charakterlich) o della natura «combattiva» della democrazia! Sono espressioni che vengono dal cuore — il Terzo Reich avrebbe detto «dall’essenza» — della LTI. È per pedanteria che me ne sento urtato, per quel tanto di pedantesco che si annida in ogni filologo? Risponderò alla domanda con un’altra domanda. Qual era il mezzo di propaganda più efficace del sistema hitleriano? Erano i monologhi di Hitler e di Goebbels, le loro esternazioni su questo o su quell’oggetto, le loro istigazioni contro l’ebraismo o il bolscevismo? Certamente no, perché molto non veniva compreso dalle masse, annoiate d’altra parte dalle eterne ripetizioni. Quante volte, finché potevo frequentare le trattorie (non portavo ancora la stella) e più tardi in fabbrica durante la sorveglianza antiaerea, quando gli ariani e gli ebrei stavano in locali separati e in quello ariano c’era la radio (oltre al riscaldamento e al cibo), quante volte ho sentito sbattere sul tavolo le carte da gioco e chiacchierare ad alta voce sul razionamento del tabacco o della carne oppure su qualche film durante i prolissi discorsi del Führer o di uno dei suoi paladini; però il giorno dopo i giornali affermavano che il popolo intero aveva prestato ascolto. No, l’effetto maggiore non era provocato dai discorsi e neppure da articoli, volantini, manifesti e bandiere, da nulla che potesse essere percepito da un pensiero o da un sentimento consapevoli. Invece il nazismo si insinuava nella carne e nel sangue della folla attraverso le singole parole, le locuzioni, la forma delle frasi ripetute milioni di volte, imposte a forza alla massa e da questa accettate meccanicamente e inconsciamente. Di solito si attribuisce un significato puramente estetico e per così dire «innocuo» al distico di Schiller: «La lingua colta che crea e pensa per te». Un verso riuscito in una «lingua colta» non è una prova sufficiente della capacità poetica del suo autore; non è poi tanto difficile, usando una lingua estremamente colta, atteggiarsi a poeta e pensatore. Ma la lingua non si limita a creare e pensare per me, dirige anche il mio sentire, indirizza tutto il mio essere spirituale quanto più naturalmente, più inconsciamente mi abbandono a lei. E se la lingua colta è formata di elementi tossici o è stata resa portatrice di tali elementi? Le parole possono essere come minime dosi di arsenico: ingerite senza saperlo sembrano non avere alcun effetto, ma dopo qualche tempo ecco rivelarsi l’effetto tossico. Se per un tempo sufficientemente lungo al posto di eroico e virtuoso si dice «fanatico», alla fine si crederà veramente che un fanatico sia un eroe pieno di virtù e che non possa esserci un eroe senza fanatismo. I termini fanatico e fanatismo non sono un’invenzione del Terzo Reich, che ne ha solo modificato il valore e li ha usati in un solo giorno con più frequenza di quanto non abbiano fatto altre epoche nel corso degli anni. Il Terzo Reich ha coniato pochissimi termini nuovi, forse verosimilmente addirittura nessuno. La lingua nazista in molti casi si rifà a una lingua straniera, per il resto quasi sempre al tedesco pre-hitleriano; però muta il valore delle parole e la loro frequenza, trasforma in patrimonio comune ciò che prima apparteneva a un singolo o a un gruppuscolo, requisisce per il partito ciò che era patrimonio comune e in complesso impregna del suo veleno parole, gruppi di parole e struttura delle frasi, asservisce la lingua al suo spaventoso sistema, strappa alla lingua il suo mezzo di propaganda più efficace, più pubblico e più segreto. Rendere evidente il veleno della LTI e mettere in guardia da esso credo sia qualcosa di più che pura e semplice pedanteria. Quando un ebreo ortodosso ritiene che una stoviglia sia diventata impura, la purifica sotterrandola. Bisognerebbe seppellire in una fossa comune molte parole dell’uso linguistico nazista, per lungo tempo, alcune per sempre.
Victor Klemperer
* Parteigenossen: iscritti al partito nazista
Tratto da LTI La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, 2011
Dall’arrivo di Hitler al potere nel 1933 fino alla capitolazione tedesca nel 1945, Victor Klemperer, professore di filologia all’Università di Dresda, tenne un diario segreto in cui raccontava la vita quotidiana di un ebreo tedesco durante il Terzo Reich. Ma il vero soggetto dei suoi appunti era la nascita e la diffusione della lingua nazista — da lui ribattezzataLTI (Lingua Tertii Imperii): Lingua del Terzo Impero — una nuova lingua parlata da tutti, da Goebbels e dall’uomo della strada, dai carnefici della Gestapo e dalle loro vittime. Resistere alla tirannia di questa lingua avvelenata, disvelarne le menzogne e le aberrazioni, diventò per Klemperer più importante della stessa sopravvivenza. Mescolando gli appunti di Victor Klemperer a filmati e registrazioni sonore dell’epoca, il documentario La lingua non mente di Stan Neumann mostra in quale modo il totalitarismo si insinui nelle menti, si stampi sulle bocche, si impadronisca dei corpi, giorno dopo giorno, infidamente.
Il cigno nero proietta:
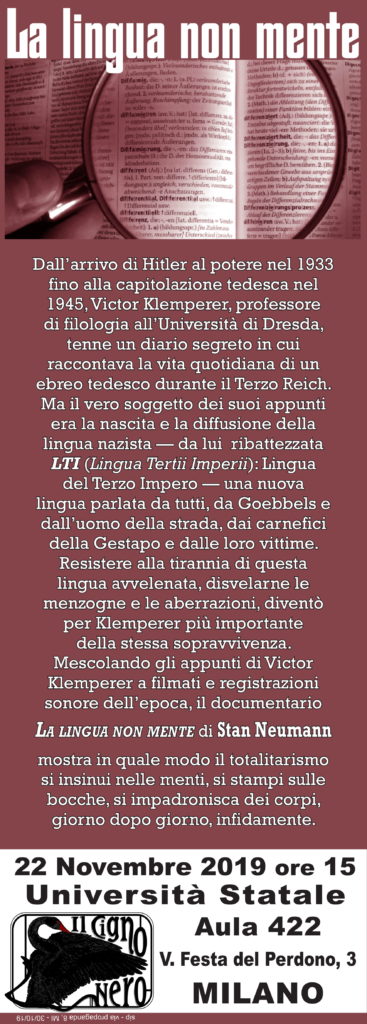
Sopra il vulcano

«Rendiamo omaggio a un vulcano? Alle voci sotterranee che lo annunciano, alla cupa aridità che lo circonda, a quella cappa minerale che improvvisamente si spalanca in un raggio di fulmini che frantuma l'orizzonte?» Annie Le Brun
Lo scorso 8 ottobre, in un incontro con la stampa, il presidente cileno Sebastián Piñera aveva definito il proprio paese «una vera oasi dentro un'America Latina confusa», potendo infatti contare — a differenza dei suoi vicini — su «una democrazia stabile». Solo dieci giorni dopo, venerdì 18 ottobre, davanti alla rivolta che deflagrava nelle strade del paese, è stato costretto a decretare lo stato d'emergenza e a disseminare Santiago e le altre città di militari come non se ne vedevano dai tempi di Pinochet. Questa clamorosa smentita della pacificazione sociale raggiunta è stata subito seguita da un’altra, quella della propaganda statale imperante. Domenica 20 ottobre, spalleggiato dai suoi generali, Piñera spiegava ai giornalisti come i disordini fossero opera di «gruppi violenti... in guerra contro tutti i cileni che vogliono vivere in democrazia. Siamo in guerra contro un nemico potente e implacabile che non rispetta nulla e nessuno». Ma poiché le immagini diffuse ovunque nel mondo stavano semmai dimostrando al di là di ogni possibile dubbio l’esatto contrario, ovvero come «tutti i cileni» (ad eccezione dei tirapiedi del potere) stessero prendendo parte alla protesta, due giorni dopo il presidente ha chiesto pubblicamente «perdono per non aver compreso in tempo il malessere sociale». Ecco qui un magnifico esempio di come ogni sicumera istituzionale, nonostante le sue tronfie apparenze ed i mezzi a sua disposizione, possa rischiare di svanire da un momento all'altro. Pur avendo reso impensabile ogni alternativa radicale all'obbedienza, chi ha forgiato questo mondo a propria immagine e somiglianza non può impedire che la riproduzione della miseria quotidiana venga interrotta. Se non più da una tensione utopica o da un progetto rivoluzionario, almeno dall’imprevisto. Quell’imprevisto che sfugge immancabilmente a chi si ostina a misurare la realtà, a calcolarla attraverso la triste computazione della politica. Che i parametri ed i criteri usati siano istituzionalmente sciatti o sovversivamente scaltri, cosa importa? Resta il fatto che non si incatenano i vulcani. Se già in passato raramente le insurrezioni sono state il frutto della strategia vincente messa in atto da un’organizzazione efficace nel portare avanti la giusta politica, oggigiorno una simile ipotesi può fare breccia solo nella più sinistra dabbenaggine. Ipotesi ridicola da avanzare soprattutto in paesi che vantano una democrazia di stampo più o meno occidentale, laddove la cosiddetta «coscienza di classe» è stata sradicata da decenni di confortevole (tele)consumo — ma dove in compenso può covare una rabbia, un malessere, un'angoscia, una disperazione di vivere, che non sono eliminabili né con un programma di partito da attuare, né con una rivendicazione specifica da reclamare. Si tratta di foschi sentimenti che si accumulano per anni, non certo per presentarsi alla fine a pretendere i dovuti interessi. Il più delle volte si limitano a brontolare in maniera minacciosa, incutendo timori (e suscitando speranze) tanto comprensibili quanto fuori luogo. Ma quando hanno occasione di manifestarsi, lo fanno in maniera terribile. Non attraverso radicati movimenti di lotta dotati della loro brava legittimità politica da sbandierare per raccogliere unanime consenso, ma attraverso inaspettate esplosioni sociali. Improvvise ed incontrollabili, come l'eruzione di un vulcano. È quanto sta accadendo da un mese esatto dall'altra parte dell'oceano, in Cile, dove il magma incandescente si è sparso nelle strade delle città come sui pendii del Nevados de Chillán, incenerendo ogni cosa al suo passaggio. Come tutte le esplosioni sociali, anche questa ha avuto bisogno di un banale pretesto che ne facesse da scintilla. La chispa, in questo caso, è stata l'annunciato aumento del biglietto dei trasporti pubblici durante le ore di punta. È bastato qualche giorno di agitazione, con un rifiuto di massa di pagare il balzello, per spingere il governo a tirar fuori tutta la sua feroce tracotanza. Ancora una volta, l'ottusità di chi detiene il potere si è rivelata un ingrediente fondamentale per la generalizzazione della rivolta. Le maniere forti del generale Javier Iturriaga, unite all'atteggiamento strafottente della classe dirigente, non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente la protesta, che è presto dilagata in tutto il paese. Lo stato di emergenza decretato venerdì 18 ottobre da «Piñera cagón» non ha spaventato nessuno. Anziché assistere ad un immediato e scodinzolante ritorno all'ordine, i militari si sono visti circondati ed affrontati da migliaia di uomini e donne che hanno eretto barricate, saccheggiato negozi, incendiato autobus, distrutto stazioni metropolitane, dato alle fiamme palazzi. Settimana dopo settimana, né gli arresti di massa o gli occhi bucati nelle strade, né le torture o gli stupri nelle caserme, sono riusciti a fermare insorti resi forti dalla consapevolezza che non avevano più nulla da perdere a rifiutare la quotidianità imposta (l'urlo di guerra con cui gli insorti cabili avevano aperto il terzo millennio, «non potete ucciderci perché siamo già morti», è stato ripreso a modo loro dagli insorti cileni: «ci hanno derubato a tal punto che ci hanno rubato anche la paura»). Ovviamente il pretesto iniziale della sommossa è stato dimenticato in fretta, motivo per cui il dietrofront del governo sul rincaro delle tariffe non ha calmato affatto gli animi. Ovviamente il governo ha proposto un tavolo di confronto «ampio e trasversale», a cui le forze politiche di sinistra si sono rifiutate di partecipare fintanto che i militari erano in strada. Ovviamente queste stesse forze si sono guardate bene dall'indire subito uno sciopero nazionale per contrastare la repressione statale, dovendo prima appurare di avere davanti un «popolo» da rappresentare, e non pochi «vandali» da legittimare. Ovviamente più la rivolta continuava imperterrita, più i partiti di destra e di sinistra trovavano un compromesso per dare vita ad una Unità Nazionale salvifica delle istituzioni. Tuttavia, fino ad ora la routine politicarda si è rivelata del tutto incapace di placare una rabbia che, non riconoscendo leader, non presta nemmeno margini di manovra al recupero. Alla sua genesi avranno anche contribuito i riverberi provenienti dai rondò in Francia o dalla comune di Quito in Ecuador, ma gli insorti cileni non hanno portavoce pronti a farsi intervistare, né assemblee da cui farsi rappresentare, né confederazioni alle cui decisioni sottostare. E ciò che da un lato getta nel panico la classe dirigente, dall'altro mette in imbarazzo l’aspirante ceto dirigente.
«L'idea che sarebbe possibile “radicalizzare” una lotta importandovi tutto il bazar di pratiche e di discorsi reputati essere radicali disegna una politica da extraterrestri» Comitato Invisibile, "Ai nostri amici", 21 ottobre 2014
«Siamo completamente sopraffatti, è come un'invasione straniera, extraterrestre, non so come dire, e non siamo attrezzati per combatterli» Cecilia Morel, moglie del presidente Piñera, 21 ottobre 2019
Considerato come i fatti che stanno accadendo in Cile siano ricchi di suggerimenti e spunti su cui riflettere per riuscire a pensare l'insurrezione, a cogliere le possibilità da giocare per renderla irreversibile, non ci sembra davvero un caso se vengono taciuti sia dagli organi di Stato che da quelli del contro-Stato. Mentre il presidente Piñera mette al sicuro la sua famiglia mandandola in Australia, i vari militanti di sinistra mettono al sicuro la propria ideologia parcheggiando il loro cervello in Rojava, o avviluppandolo in un gilet giallo. Perché in Cile non c'è un partito rivoluzionario da sostenere, non c'è un leader carismatico da seguire, non c'è un esercito di popolo a cui aderire, non c'è una bandiera da agitare, non c'è un territorio da difendere; e non ci sono nemmeno lotte sociali da far convergere, classi proletarie da ricomporre, movimenti di base da organizzare. Il che spiega il motivo per cui i cantori della conflittualità alternata, del potere parallelo, della destituzione, davanti all'esplosione cilena che sta distruggendo tutto... si limitano ad annotare la brutalità della repressione che ha scatenato. Non si tratta di ritardo storico o di ottusità ideologica. Si tratta, oseremmo dire, di baratro antropologico. Gli abitanti della terraferma ben piantata nell'autorità non sono letteralmente in grado di capire gli abitanti delle stelle fluttuanti nella libertà. Ci sia permesso di fare qui un piccolo esempio. L'incendio di veicoli del trasporto pubblico è una pratica diffusa da anni fra le teste calde cilene, le quali sono state più volte criticate dagli accorti strateghi della rivoluzione (inorriditi da come si potesse fare ricorso ad azioni così poco comprensibili: bruciare degli autobus è vandalismo, non porta nessun consenso popolare!). Ma a partire dal 18 ottobre scorso, ecco che quella pratica acquisiva d'un tratto senso agli occhi di tutti. Ciò che era stato bollato come miopia diventava lungimiranza, e le parole scritte 7 anni fa in proposito da alcuni anarchici belgi («La gran maggioranza degli utenti dei trasporti pubblici li utilizzano per spostarsi da casa verso il lavoro, verso istituzioni, verso appuntamenti con burocrati, verso luoghi di consumo come il supermercato, lo stadio o la discoteca. Ciò fornisce una leggera spiegazione per comprendere l'importanza che il potere attribuisce ad una rete di trasporti pubblici che funzioni decentemente. Lo spostamento, la circolazione di persone è fondamentale per l'economia, per l'esistenza del potere... La mobilità totale e quotidiana della popolazione necessita di adeguate infrastrutture. L'importanza di queste infrastrutture per l'ordine sociale emerge al contrario allorquando queste vengono paralizzate, poco importa la causa: ritardi, caos, disordine, rottura della routine. Si potrebbe definire un terreno fertile per la libertà, ben altro rispetto alla riproduzione quotidiana dei ruoli, del potere, dell'economia... Paralizzare la circolazione orchestrata e condizionata significa null'altro che battersi per la libertà di tutti», Hors Service, n. 24, 7/1/2012) cessavano di apparire una difficile difesa ideologica per rivelarsi una felice quanto facile intuizione. In chi non crede in un progresso lineare che segue ferree leggi storiche — l'idiota determinismo che ha reso i marxisti «la peste della nostra epoca, la maledizione del movimento operaio» — diventa necessario preparare ed attuare fin da subito la rottura con l'esistente. Non attendere la Grande Sera che ineluttabilmente verrà in virtù di chissà quale meccanismo oggettivo, ma cominciare: cominciare, con volontà e determinazione, ad essere e fare ciò che non è mai Stato. Tutto il resto, al di là di chiacchiere più o meno dotte, emana un deciso afrore di riformismo. In un breve video girato nei giorni scorsi per le strade cilene si vede un ragazzo con un megaschermo al plasma ancora imballato sulle spalle che si sta allontanando dopo un saccheggio, il quale viene fermato da altri insorti che gli tolgono dalle mani il lussuoso dispositivo tecnologico per gettarlo nel fuoco fra danze e urla generali di gioia. Il ragazzo aveva capito che una black riot offre opportunità assai maggiori di qualsiasi Black Friday per poter infine godere delle merci più ambite, ma gli altri insorti (nessuno dei quali nerovestito e mascherato, tutti a volto scoperto come persone comuni) hanno capito che il senso della rivolta non è quello di rendere tutti partecipi del consumismo, ma di porre fine al mondo che conosciamo: a cosa può mai servire un televisore quando la rivolta è fuori dall'uscio di casa? A chi interessa lo spettacolo quando davanti agli occhi c'è finalmente la vita? Ora, cosa ci dicono i supermercati devastati, le infrastrutture distrutte, le chiese profanate e devastate, le sedi di tutti i partiti attaccate, le armerie assaltate, i monumenti abbattuti, l'intero paese messo a ferro e a fuoco da migliaia e migliaia di uomini e donne di ogni età, in preda all'inebriante desiderio che nulla possa continuare a funzionare come prima? Svanita l'illusione che si fosse davanti a un effimero sfogo di piazza, si tratta forse di un invito politico a redigere tutti assieme una nuova Costituzione, a ottenere un cambio della guardia nell'esercizio del potere? No di certo. Per creare una vita che sia tutt'altro bisogna, come diceva un poeta alla ricerca dell'oro del tempo, continuare ad avanzare nella sola maniera valida che ci sia: attraverso le fiamme.
Finimondo, 17/11/19
