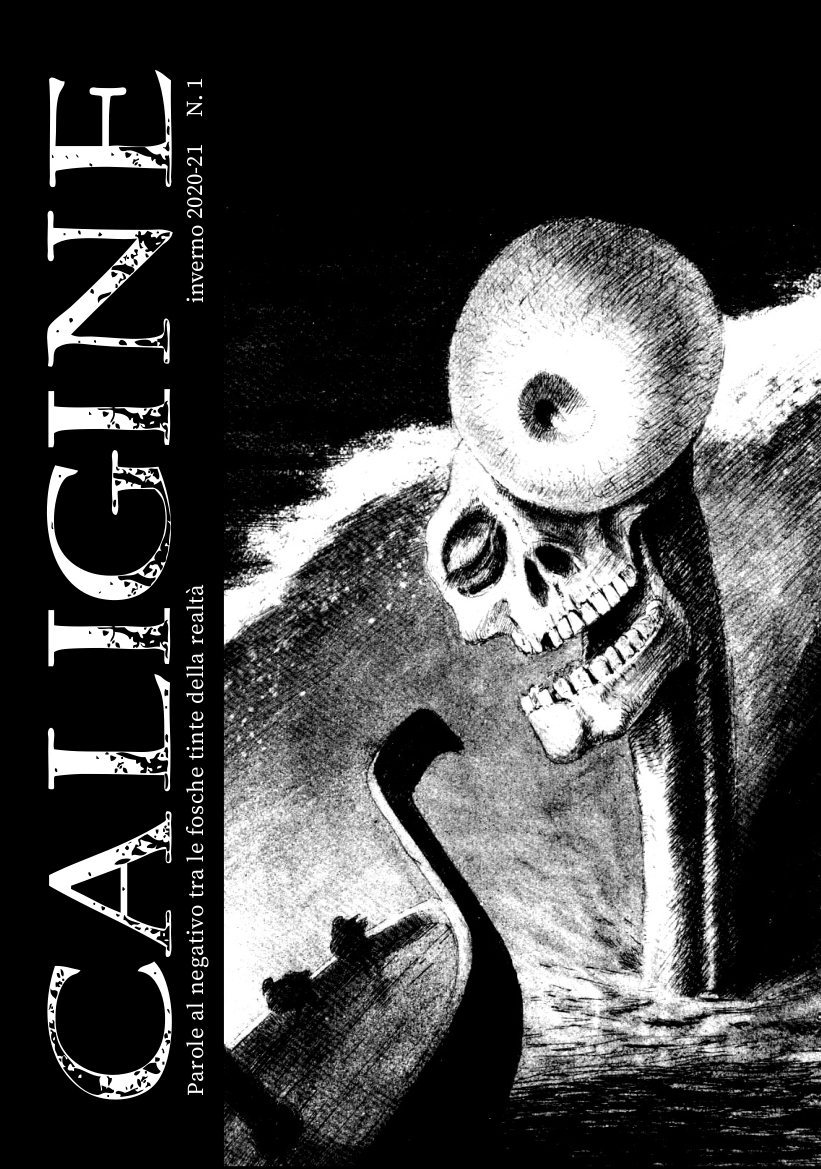Parafrasando una celebre quanto provocatoria riflessione formulata da un intellettuale tedesco all'indomani della seconda guerra mondiale, vien voglia di chiedersi se scrivere un testo di critica sociale dopo il Covid 19 non sia un atto di barbarie che avvelena la consapevolezza stessa del perché è divenuto impossibile oggi scrivere testi di critica sociale. Con ciò non si intendono equiparare i campi di stermino nazisti agli odierni reparti ospedalieri democratici, semmai interrogarsi se l'inimmaginabile enormità di quanto sta avvenendo non renda patetica e superflua ogni ulteriore analisi della realtà. Se in passato lo Sterminio burocratico di milioni di ebrei ha ucciso la poesia, oggi la Servitù Volontaria sanitaria di miliardi di esseri umani non ha forse ucciso la critica, rendendo anch'essa in-scrivibile, il-leggibile, im-praticabile? Se lo Sterminio ha messo fine alla ricerca della bellezza, la Servitù Volontaria non sta mettendo fine alla ricerca di significato? Con questa premessa, che senso ha ostinarsi a diffondere un qualsivoglia pensiero critico in una società che — trasversalmente, dall'alto in basso — cerca in tutti i modi di essere spensierata, ovvero di non dover pensare a nulla, non essendo disponibile ad ascoltare e ricevere alcuna critica? Chi potrebbe mai interessarsi a questo pensiero altro, chi trascorre le proprie giornate a «chattare» nei social network? Chi liquida come negazionismo o ideologia qualsiasi messa in discussione delle (altrui) convinzioni introiettate come proprie? Chi si preoccupa ossessivamente di indossare correttamente la mascherina, di garantire il distanziamento sociale, di venire al più presto vaccinato? O chi, animato da pruriginosi intenti radicali, organizza qualche «chiacchierata» sul conto di qualche «narrazione»? Ci sembra che quanto sta accadendo da quasi un anno in tutto il mondo — le scomposte reazioni alla diffusione di un virus poco più che banale, fra stati di emergenza che negano ogni libertà e psicosi di massa che scatenano qualsiasi brutalità — abbia fatto piazza pulita di ogni benché minima illusione necessaria sulle residue capacità della critica di contrastare lo sgretolamento del senso. Dopo una così formidabile, simultanea e planetaria dimostrazione di annichilimento delle intelligenze, chi si sente di scommettere ancora sulla possibilità di un risveglio delle coscienze? Quanta spavalda schizofrenia è necessaria per sorvolare sull'ovvietà che, per risvegliarsi, la coscienza dovrebbe comunque esistere, palesarsi, essere viva, seppur addormentata e sepolta sotto uno strato di automatismi? Si tratta di un’ipotesi impossibile da prendere in considerazione oggi, dopo aver visto milioni (se non miliardi) di persone invocare maggior coercizione, giustificare ogni controllo, partecipare alla delazione, senza il minimo scrupolo, con rabbia e determinazione. Facciamo un paio di piccoli esempi. I mass media sono riusciti, senza sollevare ondate di ilarità, a dare notizia della produzione di un vaccino contro il coronavirus la cui efficacia, dichiarata al 94%, arriverebbe al 100% nei casi più gravi. Ora, come dovrebbe essere universalmente risaputo, un vaccino va somministrato a persone sane per evitare che si ammalino e quindi non ha alcun senso darlo ai pazienti che versano in gravi condizioni. Se invece non si tratta di un vaccino, bensì di un intruglio terapeutico, allora sì che andrebbe somministrato a chi è già ammalato — ma in questo caso non avrebbe senso spacciarlo per vaccino, né soprattutto farlo assumere a chi gode di buona salute. Davanti alla minaccia pandemica pare quindi che la scienza medica abbia superato Gesù Cristo nell'arte di compiere miracoli: non solo ha creato un vaccino contro un virus misterioso in soli 7 mesi, ma per di più è efficace sia come vaccino preventivo che come farmaco curativo! Quanto ai suoi effetti collaterali, è di non molti giorni fa la notizia che in Norvegia si sono registrati decine di morti fra coloro a cui era stato somministrato. Preoccupate che ciò avrebbe fomentato i dubbi e i timori di gran parte della popolazione (influenzata dall'ignorante propaganda dei cattivi no-vax, anziché dall'informazione oggettiva dei buoni scienziati), le autorità sanitarie norvegesi hanno fornito questa spiegazione: «per pazienti con più grave fragilità, anche gli effetti collaterali relativamente lievi dei vaccini possono avere gravi conseguenze». E ciò può essere senz'altro vero, tanto quanto per pazienti con più grave fragilità, anche gli effetti relativamente lievi di un virus possono avere gravi conseguenze. Senza accorgersene, le autorità sanitarie norvegesi hanno ripreso la stessa argomentazione sostenuta da quasi un anno a questa parte da chi non prova il minimo senso di panico ad uscire di casa, respirare, sfiorare e toccare gli altri. Il vaso trabocca perché è colmo fino all'orlo, è assurdo demonizzare l’ultima goccia. Solo un'umanità che non sa né ricorda più se sia in guerra con l'Eurasia o con l'Oceania, può terrorizzarsi se il colpo di grazia ad ultraottantenni ammalati lo dà un virus e tranquillizzarsi se a darlo è un vaccino. Eppure, è proprio il cosiddetto vaccino — e non il virus — a venire intenzionalmente somministrato. Eccolo qui, il nostro tormento. Cosa resta da dire a chi è palesemente, caparbiamente, furiosamente convinto che due più due fa cinque? Oltre settant'anni fa Orwell scriveva che per il potere «da parte dei proletari, in particolare, non vi è nulla da temere: abbandonati a se stessi, continueranno — generazione dopo generazione, secolo dopo secolo — a lavorare, generare e morire, privi non solo di qualsiasi impulso alla ribellione, ma anche della capacità di capire che il mondo potrebbe anche essere diverso da quello che è». E ciò non riguarda solo i bravi cittadini, quelli per bene, quelli più usi ad acconsentir tacendo. Come ammoniva Primo Levi, «un regime disumano diffonde ed estende la sua disumanità in tutte le direzioni, anche e specialmente in basso... corrompe anche le sue vittime ed i suoi oppositori». Una società dal funzionamento totalitario, come quella in cui viviamo, ottiene il medesimo effetto. Come stupirsi e indignarsi delle telefonate delatorie di onesti cittadini alla vista di qualcuno che si bacia per strada, o dei Trattamenti Sanitari Obbligatori inflitti a chi invita la gente ad uscire da casa, o della radiazione di medici dubbiosi sulla vaccinazione, quando ci sono comunisti antistalinisti che ammirano le drastiche misure anti-pandemia prese da governi orientali, anarchici anti-tecnologici che invitano a battersi per la vaccinazione gratuita, anarco-comunisti che si vantano di disinfettare il megafono da passare di mano in mano, critici radicali entusiasti della capacità auto-organizzativa di fare da tappabuchi alle mancanze statali, sindacalisti rivoluzionari che garantiscono il distanziamento sociale, intellettuali moltitudinari che rivendicano il comunismo dei vaccini, militanti insurrezionalisti che condividono le preoccupazioni sanitarie istituzionali pur di avere qualcosa da narrare agli operai in sciopero... Sommersi dalla nausea, ci ritroviamo di nuovo tentati a parafrasare Adorno e sostenere che l'emergenza pandemica ha dimostrato inconfutabilmente il fallimento della cultura e che tutta la cultura dopo il Covid 19, compresa la critica urgente ad essa, è spazzatura. Poiché essa si è restaurata dopo quel che è successo nel suo paesaggio senza resistenza, è diventata completamente ideologia. Chi parla per la conservazione della cultura radicalmente colpevole e miserevole diventa collaborazionista, mentre chi si nega alla cultura favorisce immediatamente la barbarie, quale si è rivelata essere la cultura. Neppure il silenzio fa uscire dal circolo vizioso: esso razionalizza soltanto la propria incapacità soggettiva con lo stato di verità oggettiva e così la degrada ancora una volta a menzogna. Intrappolati all'interno di questo circolo vizioso, non si intravedono vie di fuga. Il processo di disincanto della vita non ha raggiunto il suo apice nelle atrocità più crudeli commesse nel secolo scorso. La porta resta sempre aperta all'oscurantismo, come testimoniano gli elicotteri sollevati per braccare chi si prende la tintarella in spiaggia, i linciaggi di chi esce di casa per fare ginnastica o portare a spasso il cane, per non parlare del silenzio sulle morti avvenute durante le proteste scoppiate in carcere, proteste — giova ricordarlo — nate per le restrizioni subite e poi recuperate e trasformate in richieste di maggiore tutela sanitaria. Davanti a questa realtà, terrificante e sotto gli occhi di tutti, quali parole restano? Dovremmo commentare l’assalto fallito a Capitol Hill per meglio tacere sull’assalto vittorioso ai nostri desideri? Proprio quando si appresta a compiere il suo decimo ed ultimo anno di vita, Finimondo si accorge di non aver ormai più nulla da dire. O meglio, di non voler più dire al nulla. Ed il problema, contrariamente a quanto pensano alcuni, non è lo strumento tecnico. Le parole non diventano in sé stolte non appena vengono proiettate su uno schermo, né in sé intelligenti non appena vengono vergate su carta. È però vero che la lettura su carta stampata richiede uno sforzo che allontana automaticamente chi è abituato a lanciare facili cinguettii, operando così una selezione necessaria. È quindi alla pubblicazione di libri che intendiamo in futuro dedicarci assai più che a siti in grado solo di fare schiuma alla superficie degli avvenimenti. Finimondo è quindi destinato a spegnersi progressivamente, scomparendo dalla rete nel prossimo periodo.
Probabilmente Adorno non avrebbe mai scritto nel 1949 quelle parole sulla poesia se avesse conosciuto Bożena Janina Zdunek, una giovane polacca combattente nella resistenza clandestina, catturata dalla Gestapo e liberata da Auschwitz nel 1945. Quando uscì dal campo di sterminio, aveva in tasca un quadernetto di 32 pagine che le detenute si passavano di mano in mano e che lei avrebbe conservato per tutta la vita. Bożena Janina Zdunek è morta nel 2015 e suo figlio ha di recente donato quel quaderno al Museo di Auschwitz. Al suo interno ci sono i pensieri e le poesie che le prigioniere ebree scrivevano di nascosto, in quotidiana attesa della morte. Non dopo o prima di Auschwitz, ma durante e dentro Auschwitz. Atto di barbarie? No, atto di resistenza davanti all'indicibile — la vita, nonostante tutto! Ma quel quadernetto così prezioso le prigioniere di Auschwitz erano costrette a nasconderlo, sottraendolo alle perquisizioni, ai controlli, agli sguardi degli aguzzini. Era questa la condizione preliminare per continuare a scrivere poesie, perfino dentro un campo di sterminio. Che si tratti di un'esigenza valida anche oggi per la critica sociale? Che il pensiero critico, quale che sia, non possa che essere confidenziale? Che ruminare rancorosamente sulla propria marginalità, tipico assillo di politicanti in erba, sia solo l'effetto di un'inconfessabile vanità? Viviamo in territorio nemico, davvero non ce ne siamo accorti? Smettiamola con le allucinazioni consolatorie (il popolo, le masse, il proletariato, il movimento…) e traiamo le dovute conseguenze. Ad esempio, come diceva il Divino Marchese, che ci rivolgiamo solo a coloro che sono capaci di capirci. O, sull’altro versante, che Caracremada sapeva che fare assai meglio di Lenin o Malatesta.
Finimondo, 1 febbraio 2021